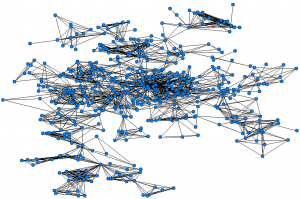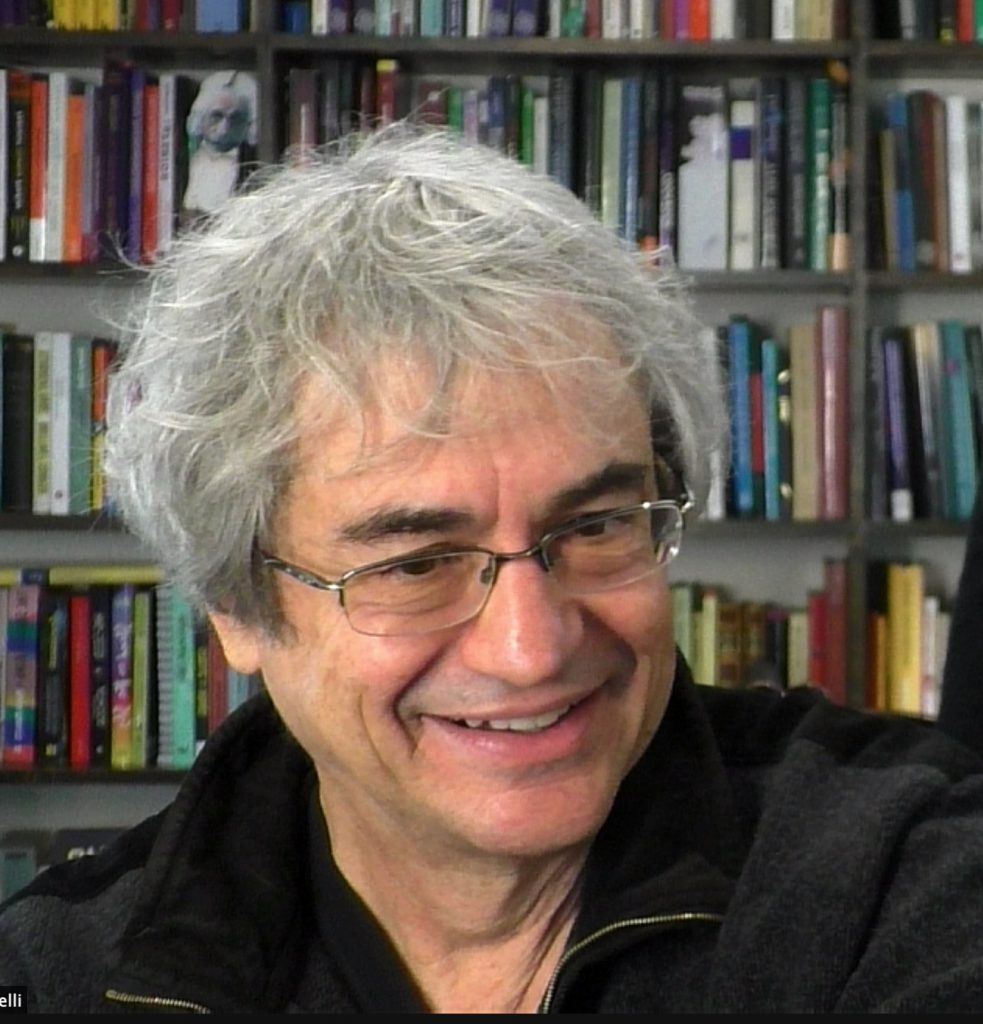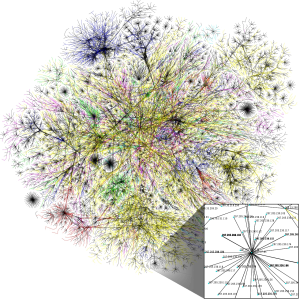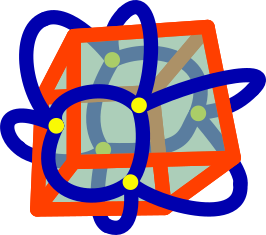Per i loro dipendenti e per i loro clienti sono professioniste e professionisti impeccabili, a volte impettiti, spesso dinamici, qualcuno autoritario, qualcuno autorevole. Ma quando varcano quella soglia qualcosa cambia: lasciano le scarpe – e la quotidianità da cui provengono – per proiettarsi in un mondo di cui spesso non hanno un’idea chiara, anche se già questa disponibilità in sé è parte del cambiamento di cui sono i protagonisti. Sono manager, dirigenti, imprenditori che Luciano Traquandi, docente di Psico-Sociologia Aziendale all’Università Carlo Cattaneo di Castellanza (Va) e di Comportamento Organizzativo alla POLIMI Graduate School of Management di Milano, porta con sé ormai da molti anni in un monastero zen in provincia di Parma, Fudenji, per vivere un’esperienza destinata a lasciare il segno. Gli abbiamo chiesto di parlarcene.
Che cos’hanno i manager da imparare in un monastero buddista di tradizione giapponese?
Chiariamo subito una cosa: questo posto in sé non è un modello per un manager. Cioè non è pensato per fornire qualcosa, come pratiche e strategie, di cui fruire immediatamente. Quindi un manager che va a Fudenji deve superare la soglia del “Vado e imparo”. Lo spirito giusto è quello di gratuità: “Vado, mi affido e aspetto l’ispirazione, o ancora meglio non mi aspetto nulla”. È una logica immersiva: si entra in un’esperienza, in una comunità che ha una sua natura, una sua tradizione, una sua solidità, e la si vive dimenticando la propria identità professionale. È l’incontro con questo spirito di gratuità che è fondamentale, insieme a un altro fattore, l’alterità, che qui è dovunque, in pratica in tutto, perché i tempi sono diversi, i ritmi sono diversi, i luoghi sono diversi, le regole sono diverse, le persone non sono quelle che incontro tutti i giorni. In poche parole, è un grande incontro con l’altro da me.
Un’esperienza di questo tipo è adatta a tutti? Oppure c’è una selezione?
Non è un’esperienza adatta a tutti; ma non è questione di scegliere, è questione di scegliersi. Alcune aziende mandano i propri dipendenti, perché ci va il leader e quindi inesorabilmente lo segue la sua prima linea. In questi casi, alcuni partecipanti sono più entusiasti, altri più refrattari; ed è normale che sia così, perché manca una vera scelta. La cosa migliore è che i partecipanti si autoselezionino; ma a parte questo l’esperienza è adatta a tutti, dal giovane neoassunto al professionista che trova assolutamente interessante rivedersi e ripensarsi a fine carriera, e anche fuori dal mondo del lavoro.

Quali sono i risultati? Ci sono effetti dimostrabili dell’efficacia dell’iniziativa?
Sì, su questo abbiamo quindici anni di esperienza. Abbiamo cominciato nel 2008 io e mia moglie, Patrizia Castellucci, e abbiamo avuto molti riscontri positivi. Quello che in genere succede è che, dopo una permanenza anche breve in monastero (almeno due notti), c’è un aumento della propria sensibilità. Cioè si notano cose, dettagli, comportamenti che prima non si vedevano, nel turbine degli impegni e stimoli quotidiani. Chi fa questa esperienza coglie in anticipo sfumature che prima avvertiva quando diventavano grandi, misurabili, quando intervenire è costoso. Questa capacità di cogliere segnali deboli è qualcosa che resta, insieme a una flessibilità sia fisica sia mentale (ottenute attraverso la meditazione, i riti, le prosternazioni). Dopo il passaggio dal monastero, le persone pensano in modi nuovi. Questo binomio sensibilità/flessibilità è un risultato che si ottiene anche in tempi brevi, con qualche giorno (e notte) di permanenza
Un’altra conseguenza che abbiamo osservato è l’importazione dei riti. Alcuni partecipanti lo hanno fatto a livello familiare, per esempio ritrovando il piacere di mangiare in casa tutti insieme, oppure lasciando le scarpe all’ingresso, come fanno i monaci. Altri lo hanno fatto sul lavoro, dove quello che abbiamo visto è una maggiore attenzione dei responsabili ai riti dei dipendenti, per esempio quello del caffè e le quattro chiacchiere del lunedì mattina o del venerdì sera, inizialmente percepiti come un fastidio, poi rispettati. Qualcuno ha cominciato a meditare, ritagliandosi uno spazio proprio in momenti tranquilli, garantiti, incorporando nella propria vita questo momento per sé come aiuto alla resilienza nei momenti difficili e come stimolo creativo nei momenti di innovazione.
C’è un esempio particolarmente significativo che si potrebbe citare?
In genere non si verifica niente di vistoso, non sono cambiamenti radicali ma sottili. Però sono socialmente percepiti. Cioè li percepiscono i familiari, i colleghi, i collaboratori, i clienti. Una volta capitò un manager, ingegnere, che andava spesso in Giappone e già conosceva la lingua e le regole di comportamento giapponesi; ma dopo essere stato a Fudenji per una classica esperienza di tre giorni riferì che i suoi contatti in Giappone avevano percepito qualcosa che rendeva più fluida la loro relazione.

Che cosa ha di specifico l’esperienza svolta in questo particolare monastero?
Fudenji si fonda su una tradizione solida, quella giapponese, molto severa, elegante, essenziale Gli ingredienti fondamentali della vita monastica sono due: la meditazione (zazen) e i riti. Il rito più impegnativo è quello del pasto. Il pasto rituale è infatti un momento topico della loro giornata nelle cosiddette “sesshin” (ritiri), che i monaci svolgono con grande rigore e precisione, sia da parte del servitore, sia da parte di chi consuma il pasto. Chi serve, è altrettanto importante di chi viene servito: a differenza di quello che avviene nel nostro mondo, che è focalizzato sul cliente, customer first.
Lei ha citato lo zazen. Che cos’è?
Lo zazen è la meditazione seduta. Il termine deriva, appunto da za (seduto) e zen. Ci si siede, si imposta il corpo e si imposta la mente. Questo è il punto di partenza. Ma è anche un punto d’arrivo, ciascuno trova la sua via. Lo zazen è una pratica meditativa dello zen. Ci sono esempi di chi pratica lo zen facendo una lezione di fisica teorica, altri lo ottengono suonando un tamburo (la pratica del taiko). Non bisogna pensarci troppo, è qualcosa che arriva da solo.
È una risposta molto bella, in realtà: trovi lo zazen nel momento in cui non lo cerchi…
Siccome non lo cerchi ti trova lui. Cioè, in qualche modo succede il contrario. Ti siedi in zazen perché ti saresti comunque seduto e potrebbe darsi che succeda qualcosa che non stai cercando. Perché se la cerchi, se la progetti, se la organizzi, se la pianifichi, allora diventa una “tecnica”, il tentativo spesso deludente di prendere il controllo di un accadimento che deve, appunto accadere.
L’organizzazione interna dei monaci è di tipo gerarchico. Anche questo può essere una fonte di ispirazione per le aziende?
L’organizzazione dei monaci in sé non è un modello adottabile da un’organizzazione. Loro stessi, in qualche modo, cercano ispirazione nel mondo esterno. Tuttavia, hanno qualcosa di speciale, che non è tanto nella struttura. È nel vissuto. Prenderei come esempio il concetto di oryoki, una parola giapponese che indica, fra le altre cose, la ciotola del pasto rituale. In giapponese, oryoki vuol dire “quanto basta”, Tutto è oryoki: la forza con cui si pulisce la superficie laccata della ciotola, il tempo in cui si lascia la zuppa sul fuoco… tutto deve essere improntato all’intercettare questo “quanto basta”, che non è uguale per tutti. E non è uguale tutti i giorni. È qualcosa che appartiene a quella situazione. Il conseguimento del giusto equilibrio è ciò che può insegnarci qualcosa.
C’è anche una componente collettiva che sembra importante.
È un mondo “corale”. Ed è questa l’importanza del rito, altrimenti diventa una performance meccanica. In qualche modo, lo schema organizzativo è questo: guardati intorno, dov’è l’altro? L’altro è avanti? Accelera. L’altro è indietro? Rallenta. Quindi l’obiettivo è quello di non pensare alla propria performance, ma a quella collettiva, anche tenendo conto di chi non è presente. La recitazione del mattino, prima della colazione, è emblematica: si ringrazia per questo chicco di riso che diecimila mani hanno seminato, coltivato, raccolto, cotto, servito e mangiato. C’è un’attenzione a tutte quelle mani che non vedrai mai. Si potrebbe semplicemente prendere una scatola di riso, cuocerlo e servirlo senza pensarci.
Alla fine, per un manager, questo è anche un modo completamente diverso di vedere la supply chain.
Certamente. Nella rete globale del commercio, la supply chain è costituita da aziende che acquistano un pezzo da un’altra azienda, lo lavorano, lo trasformano e poi lo vendono a un’altra. Ciascun attore pretende la qualità di ciò che riceve e garantisce quella di ciò che vende, cercando la massima efficienza; ma il rapporto si esaurisce con la transazione economica. La logica di Fudenji è diversa: tu azienda non hai solo la responsabilità che il tuo pezzo sia ben fatto, ma porti il frutto di tutte le mani che hanno lavorato su quel pezzo, non dimenticarlo. E a questo punto il pezzo prende anima. La spiritualità è quest’anima che arriva alle cose non tanto perché sono sante o benedette, ma perché tu le hai rese sante. Tu l’hai santificato perché hai pensato ciò che la preghiera recita di un chicco di riso: pensa a quante mani l’hanno seminato, l’hanno fatto crescere, l’hanno raccolto, l’hanno pulito, l’hanno trattato, l’hanno portato qui e l’hanno cucinato. Fudenji è un posto dove non ci sono santi, c’è la santificazione.
Link e approfondimenti
• Il sito del monastero Fudenji.
• Il nuovo corso di Luciano Tranquandi e di Patrizia Castellucci, SPEM Spiritualità e Management, alla POLIMI Graduate School of Management.