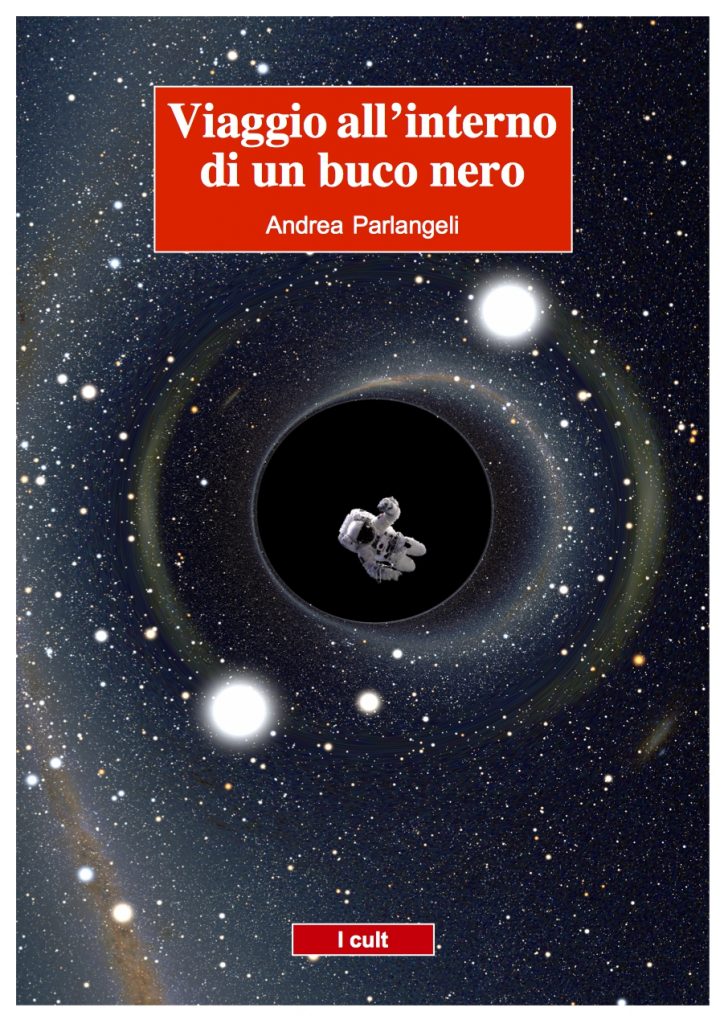Per essere un governo che si muove alla cieca, si è mosso anche abbastanza bene.
Prima un lockdown duro, che ha abbassato in modo significativo i contagi e ha raccolto consensi, a primavera. Lo si può anche criticare, perché è stato indubbiamente tardivo in alcune aree (Bergamo e Val Seriana), non preceduto da un piano pandemico degno di questo nome, lungo e oneroso in termini economici. Però ha funzionato e – complice la buona stagione – ci ha messo per un certo periodo in condizioni favorevoli.
Poi c’è stata un’altra stretta a novembre, e un’altra più che opportuna durante le recenti festività natalizie. Impopolare, forse, ma necessaria. E fin qui va bene.
In mezzo, però, troppe distrazioni. A cominciare dall’estate, in cui tutti si sono rilassati un po’ troppo nell’illusione che il peggio fosse passato. E poco si è fatto per affrontare in maniera efficace la stagione invernale. Le critiche sono tante, e più che giustificate. Vogliamo qui, però, concentrarci su un punto che è di importanza vitale per la gestione dell’epidemia, per il futuro del nostro Paese e per la democrazia. La questione che voglio affrontare è quella dei dati.
Apro una breve parentesi per chiarire che non parliamo della app Immuni, ma proprio per questo due parole sulla app è opportuno dirle. Come è sotto gli occhi di tutti, Immuni è stata un fallimento. Il problema non è stato tanto la app in sé, che tutto sommato funzionava, e nemmeno che le persone non la usavano (questa è stata più una conseguenza che la causa). Il problema vero è stato che la app era sostanzialmente inutile, in quanto i dati su cui si basava venivano caricati manualmente dagli addetti; per cui chi era entrato in contatto con un positivo lo veniva a sapere molti giorni, se non settimane, dopo. Quando, cioè, era ormai troppo tardi. Chiudo la parentesi e torno ai dati.
Di quali dati c’è, dunque, bisogno? Innanzitutto quelli sui contagi, sui ricoveri, sui decessi, sui guariti, e sull’evoluzione dell’epidemia (su questo seguirà a breve un post di un esperto). Ma quei dati ci sono già, dirà qualcuno. E proprio qui è il problema, perché quelli disponibili sono di gran lunga insufficienti. I dati non sono mai stati adeguati. Tutti ricordano la litania dei numeri forniti dalla Protezione civile a marzo, alle sei del pomeriggio, ogni giorno, e ripresi da agenzie, quotidiani, tg e siti d’informazione in tutta Italia. Quei dati servivano a giustificare le scomode decisioni politiche da comunicare; ma non ci credeva nessuno. Erano insufficienti, incompleti, tardivi, inaffidabili (se non quelli dei ricoveri e dei decessi, purtroppo). Tutti gli esperti ritenevano e dichiaravano candidamente che l’entità reale dei contagi era probabilmente dieci volte superiore a quella riportata. Ma eravamo in condizioni di emergenza, e l’emergenza giustifica tutto, anche l’approssimazione.
E così ci siamo abituati alla mediocrità. Tante cose sono migliorate, ma i dati che forniscono le autorità sono ancora di gran lunga insufficienti. Sono dati aggregati, cioè riportano in maniera più o meno fedele quel che avviene a livello nazionale, al massimo regionale. Ma i dati dovrebbero essere pubblici, tempestivi, affidabili. E poi, come si dice in gergo, “disaggregati”, cioè suddivisi per provincia, regione, città o paese, perfino quartiere. Solo così le istituzioni e i ricercatori possono prenderli e utilizzarli per analizzare la situazione e prevederne lo sviluppo.
Sulla base dei dati, è possibile prendere decisioni informate.
In assenza di dati, si naviga a vista, si va alla cieca. Già in condizioni normali, è sbagliato. Nelle circostanze in cui siamo, è intollerabile. Il prezzo sono l’impatto economico e le vite umane.
C’è un altro punto, che non è secondario. I dati sono importanti, anzi fondamentali, in una democrazia evoluta. E qui parliamo di dati in senso più ampio, in ambito di salute, ambiente, economia, i cosiddetti “open data”. In assenza di dati, è impossibile fissare obiettivi chiari. E, soprattutto, è difficile valutare se gli obiettivi dichiarati siano stati raggiunti oppure no.
Tim Berners-Lee, l’inventore del World Wide Web, sugli open data.
Per chi comanda, i dati sono scomodi: permettono di giudicare in modo obiettivo il loro operato. Questo si vede anche in molte aziende, in cui i vertici non forniscono informazioni ai dipendenti, oppure le forniscono in funzione delle decisioni che vogliono prendere, alla storia che vogliono raccontare. È più comodo, così. Per una democrazia, però, e per inciso anche per le aziende, è meglio un sistema basato sui dati e sugli obiettivi da raggiungere; un sistema che avvantaggi chi è più bravo a ottenere i risultati, invece di chi è per qualche ragione inamovibile, oppure più abile nella propaganda. È una questione di trasparenza, di efficacia, di giustizia.
Purtroppo, l’Italia non è un Paese che incoraggia gli open data. L’Italia è un Paese che incoraggia le oligarchie.
E allora, tornando alla questione dei dati e al Covid, si doveva, si poteva e si può ancora fare molto meglio di quanto è stato fatto, cioè quasi nulla. Non ci sono più scuse. È vero che rendere la pubblica amministrazione aperta ai dati richiede di ripensarne tutta l’organizzazione. È anche vero, però, che i finanziamenti ci sono, e che il governo stesso ha messo la digitalizzazione del Paese al centro della sua strategia di azione. Un segnale forte in tal senso sarebbe più che opportuno, doveroso. È una questione di trasparenza, di efficacia nella lotta alla pandemia, di economia, di eredità per i nostri figli, e purtroppo anche di vita per molte persone. Come dice una petizione che vi invitiamo a firmare, i dati vogliono uscire. Liberiamoli.
Andrea Parlangeli