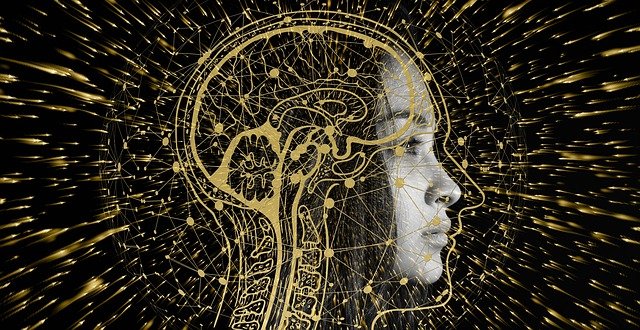Nel ricchissimo immaginario degli antichi egizi, c’era un luogo mitico ma allo stesso tempo molto concreto e reale. Era la Terra di Punt, meta di solenni spedizioni con le quali gli egizi si procuravano incenso e spezie, oro e avorio, ossidiana, lapislazzuli, legno pregiato e animali sacri. Organizzare questi viaggi alla volta di una terra lontana era per un faraone la dimostrazione del suo controllo anche sull’estero, sull’ignoto e sul caos, la capacità di aggiungere, all’ordine del suo regno, materie prime e merci “esotiche”.
Con bassorilievi e pitture, già a partire dalla IV dinastia dell’Antico Regno (2630-2510 a.C.), i re e le regine dell’antico Egitto hanno voluto fissare la memoria di quelle prestigiose spedizioni per una terra che definivano anche “Paese del dio”. Qui, secondo il mito, avrebbe avuto origini Hathor, dea del cielo e della fertilità. Tuttavia, in nessun resoconto a noi pervenuto viene indicano dove si trovasse Punt, tanto che per molti anni gli archeologi non avevano escluso che si trattasse di una leggenda propagandistica dell’aristocrazia egizia.
Merci “meravigliose”
Negli ultimi tempi, però, risalendo alla provenienza geografica di alcuni oggetti importati in Egitto con quelle memorabili spedizioni, si sta svelando l’arcano. Andrea Manzo, archeologo dell’Università L’Orientale di Napoli, da lungo tempo impegnato a risolvere il mistero, spiega: «Gli egizi qualificavano le merci da Punt con il termine “bi3” (traslitterazione dei segni piede, canna e avvoltoio, nda) che nell’antica lingua egizia significava “meraviglia”. Termine solitamente usato non tanto in relazione al fascino o al valore estetico, ma con una forte connotazione religiosa, poiché spesso impiegato per qualificare eventi prodigiosi, segni tangibili che mostravano la presenza della divinità o il suo favore legittimante nei confronti del faraone».
È quindi un caso davvero unico che delle merci venissero etichettate con bi3. Ma quelle da Punt, a partire dall’incenso, lo erano quasi sempre. «Probabilmente tutto era nato dall’importanza dell’incenso nelle funzioni religiose», continua Manzo. «Bruciare incenso e inalarlo facilitava l’estasi mistica».
Da dove viene il babbuino?
Un’altra “meraviglia” importata da Punt era il babbuino amadriade (Papio hamadryas) incarnazione del dio Thot (divinità della saggezza e della scrittura). Così, se gli studi sulla provenienza dell’incenso portano tradizionalmente all’attuale Somalia Orientale, ma anche all’Etiopia e Eritrea Occidentale e allo Yemen, questa specie, che non esisteva allo stato libero in Egitto, ha permesso di allargare il campo geografico in cui situare Punt.

Servendosi di tecniche avanzate, come l’analisi isotopica delle ossa e dei denti, recentemente alcuni ricercatori hanno concluso che gli amadriadi degli egizi provenivano da una regione che comprende gran parte delle attuali Etiopia, Eritrea e Gibuti, parti della Somalia e dello Yemen. Insomma, una Terra di Punt più vasta del previsto. «Questo testimonia le grandi possibilità della marineria egiziana nel secondo millennio a.C.», fa notare Manzo. «Si arrivava alla Terra di Punt navigando fino alle coste del Mar Rosso Meridionale».
Salta all’occhio il paradosso che la leggendaria terra dell’abbondanza oggi risulta in gran parte una delle aree più povere del mondo. Niente male come esempio di progresso diseguale. Ma da quale località esatta partivano le navi egizie alla volta di Punt? «Sappiamo che nel Medio Regno salpavano da Nord, a Mersa/Wadi Gawasis, dove abbiamo trovato i resti di un porto e merci provenienti da Punt», spiega Manzo.
Un cane con le orecchie a punta
Dalla Terra di Punt veniva importato anche un cane tipico chiamato “tsem”, con orecchie a triangolo, corpo snello e coda corta arricciata. Fu rappresentato accanto agli amadriadi sulle navi egiziane di ritorno da Punt nei rilievi della rampa processionale della piramide di Sahura (secondo re della V dinastia, al potere dal 2490 al 2475 a.C.) che si trova ad Abusir, a nord di Saqqara.
Anche a Mersa/Wadi Gawasis, si è trovata la raffigurazione di un cane simile. Lo disegnò su terra cotta (ostrakon) uno dei marinai di ritorno da Punt o forse un prospettore. Non è da escludere infatti che al seguito di queste spedizioni vi fossero esperti addetti alla documentazione. I loro disegni su terra cotta o papiro servivano da base alle rappresentazioni ufficiali di quelle imprese, poi scolpite nella pietra, come quelle di Sahura, o del tempio di Hatshepsut a Deir el Bahari, dove è ricordata la famosa spedizione organizzata dalla regina nel 1493 a.C. Ma bassorilievi su Punt già erano presenti durante la quarta dinastia (2613-2498 a.C), per esempio mostrandone un abitante insieme a uno dei figli del faraone Khufu (Cheope).
Anche su una parete del tempio di Amon, a Tebe, fatto costruire da Seti I, secondo faraone della XIX dinastia, Punt è rappresentata. Si tratta di geroglifici che raccontano di un viaggio navale per portare in patria oro, incenso e mirra, oltre a zanne di elefante, lapislazzuli, ebano, pavoni e scimmie. Sappiamo che i contatti e i commerci documentati con Punt continuarono nel Nuovo Regno durante i periodi di Amenofi II, Ramses II e III, cioè fino al 1155 a.C. In totale ci furono contatti per quasi 1.500 anni.
Ebano e ossidiana
Nell’antico porto di Mersa/Wadi Gawasis (Medio Regno), sono state trovate stecche di ebano africano. Le indagini botaniche ne hanno stabilito la provenienza dagli altopiani etiopici. Altra merce con tutta probabilità “puntita”, ritrovata in questo porto egizio del Mar Rosso, è l’ossidiana. Usata fin dal predinastico, per esempio per creare il tipico coltello rituale per “l’apertura della bocca” (favoriva l’uscita del Ka, una delle diverse anime del defunto). I ricercatori dell’Orientale di Napoli hanno individuato l’origine dell’ossidiana sia nella costa africana che in quella arabica del Mar Rosso Meridionale. Se due o più indizi (amadriadi, ebano, ossidiana) fanno una prova, la Terra di Punt doveva davvero essere molto vasta. «Non un singolo Paese, una o più città-Stato», conclude Manzo, «ma una grande regione percorsa da una o più confederazioni di tribù, per lo più nomadi, con esperti artigiani e commercianti».
Diffusi su entrambe le sponde del Mar Rosso Meridionale, i puntiti presentavano anche un certo grado di multietnicità. Una popolazione mista, composta da individui di diversa provenienza è suggerita anche dai resti scheletrici e oggetti venuti alla luce nella necropoli di Mahal Teglinos, in Sudan, condotti sempre dall’Orientale. Anche Mahal Teglinos viene considerata parte del network di Punt. Queste tribù di mercanti erano tendenzialmente pacifiche, ma non “pacifiste”. Una iscrizione trovata in una tomba di El Kab, risalente alla XVII dinastia, racconta che i puntiti si unirono al Regno di Kush in una guerra contro l’Egitto, con buona pace dell’antica amicizia.