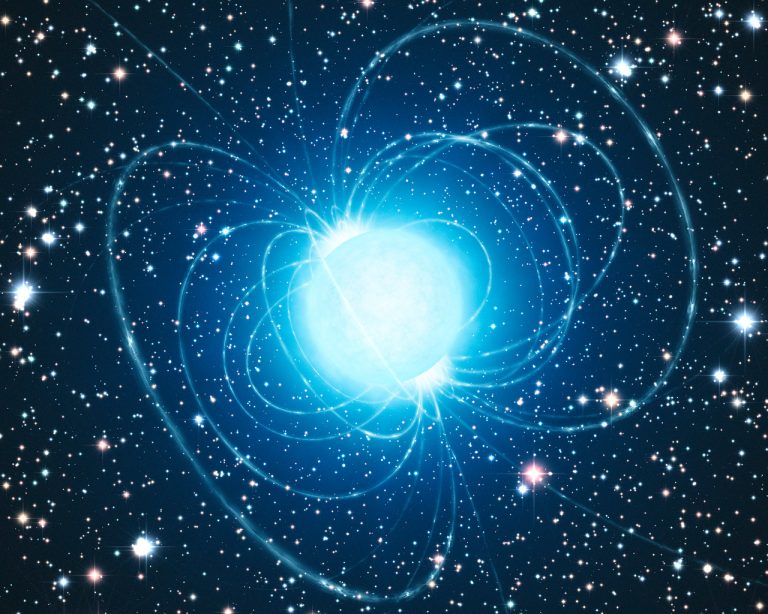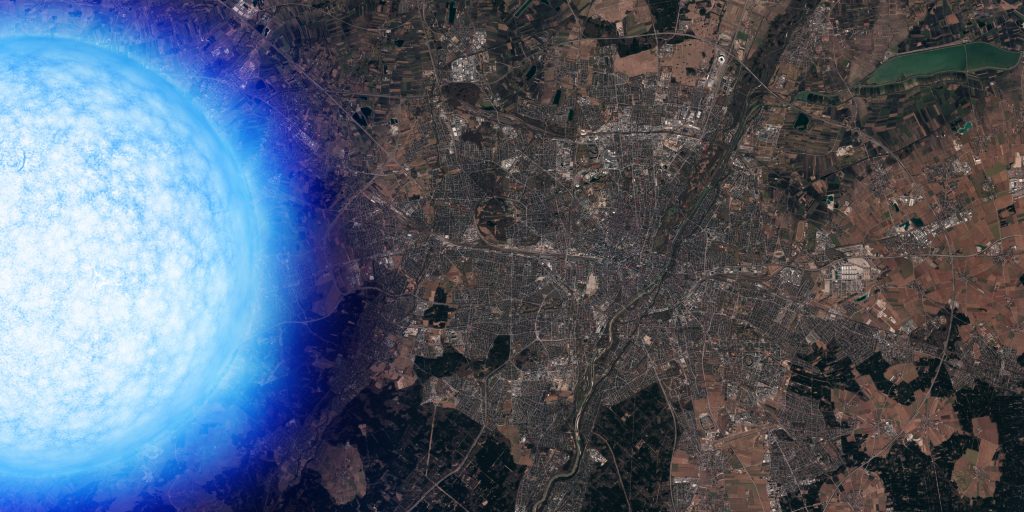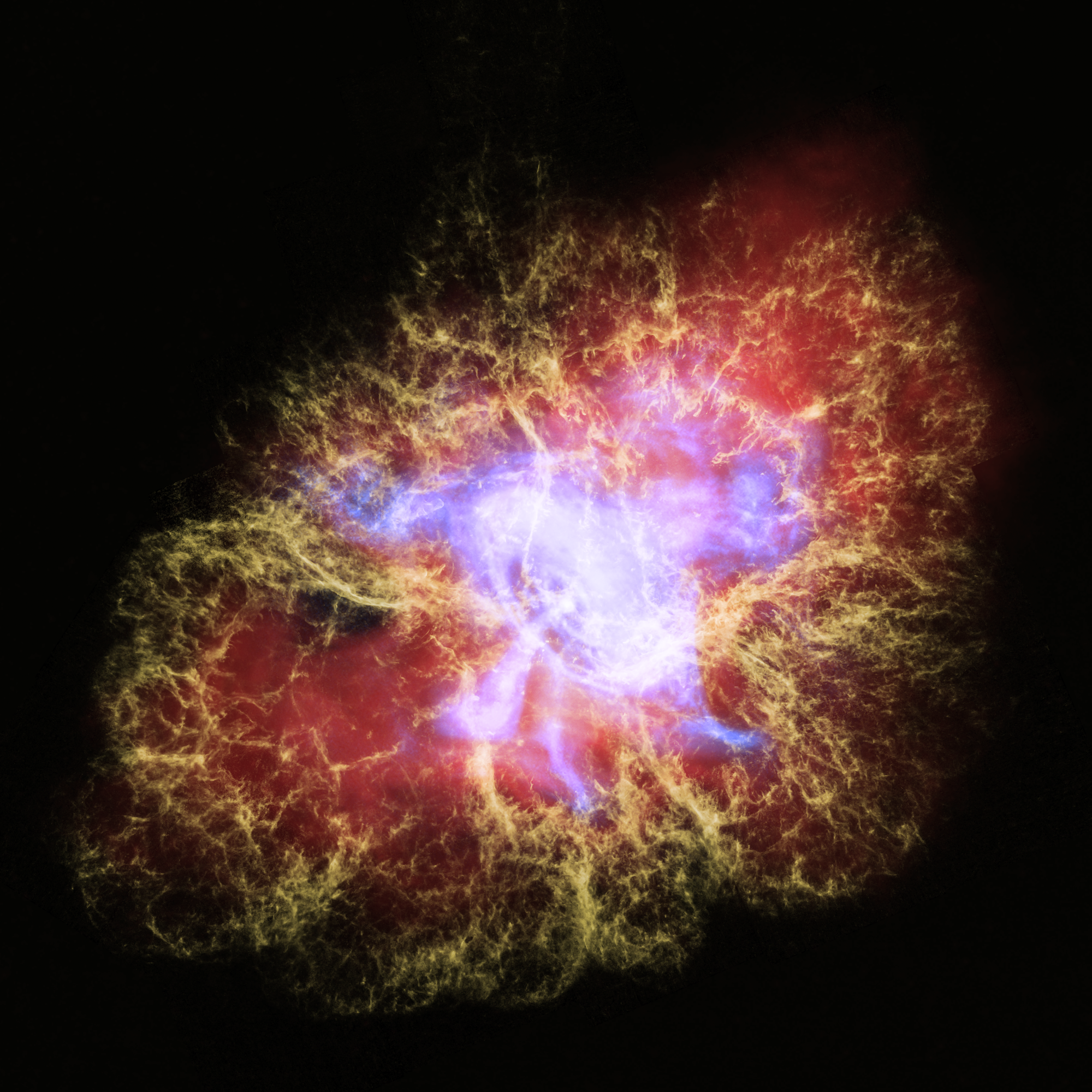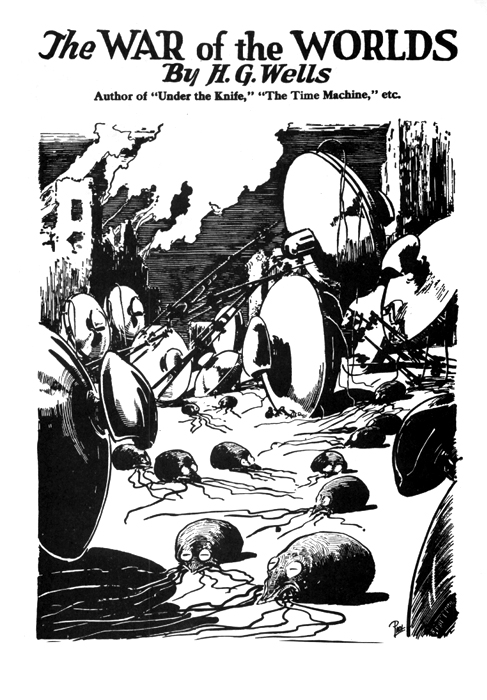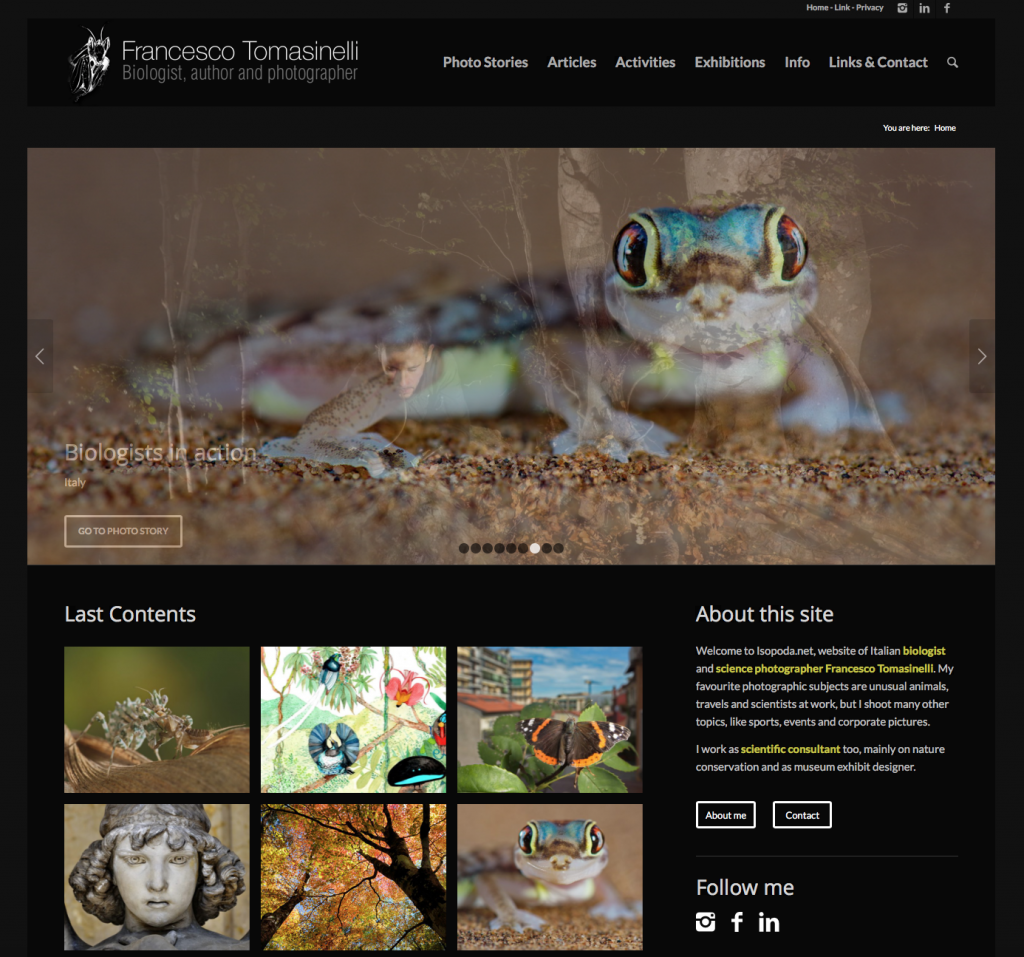La situazione è grave ma non seria, avrebbe detto Ennio Flaiano a commento della tragica Marcia su Capitol Hill che abbiamo visto sui media. Ma quella è stata solamente l’ultima pagina, la più buia, del percorso che ha portato all’elezione del nuovo POTUS. Il potus non è una qualche pianta ornamentale da appartamento, ma l’acronimo utilizzato nel mondo anglosassone per il President of the United States.
Grandi elettori. Più di qualcuno negli ultimi mesi si sarà interrogato, infatti, sui meccanismi elettorali degli Usa e su come si determini il numero dei grandi elettori. Ebbene, questi sono pari al numero dei senatori, 100, ovvero 2 per ogni Stato, più quello dei 435 rappresentanti al Congresso ripartiti tra gli Stati proporzionalmente all’ultimo censimento, più ulteriori 3 per il District of Columbia, ovvero il territorio amministrativo dove si trova Washington. Ma proprio la specificazione “proporzionalmente all’ultimo censimento” è tutt’altro che ovvia.
Il meccanismo usato per la ripartizione dei seggi al Congresso, negli Usa, è sempre stato molto controverso
Come ripartire i seggi al variare della popolazione e al variare del numero degli Stati è stata una delle vicende politico-matematiche più interessanti della storia degli Stati Uniti. Il meccanismo usato per l’allottment, ovvero la ripartizione dei seggi al Congresso, è stato sempre molto controverso. Fu modificato ripetutamente a partire dal famoso veto di George Washington, alla prima proposta di cambiamento fatta da Thomas Jefferson, fino al Teorema di impossibilità di Balinski-Young del 1983.
Tanti paradossi. Questo teorema afferma che non esiste un metodo equo da tutti i punti di vista, ovvero che assegni ad ogni Stato il numero di seggi più vicino, per eccesso o per difetto, al quoziente dato dalla popolazione totale diviso il numero di seggi, e che sia privo di casi limite paradossali. I paradossi più noti sono: il paradosso dell’Alabama, per cui in certe situazioni, potrebbero diminuire i seggi assegnati a uno Stato, anche se aumentasse il totale dei seggi messi in palio e la popolazione rimanesse uguale ovunque, e il paradosso della popolazione, per cui potrebbero diminuire i seggi attribuiti a uno Stato a favore di un altro, anche se la sua popolazione aumentasse più che nell’altro.
Il Teorema di Balinski-Young (1983) afferma che non esistono sistemi elettorali privi di paradossi
Ecco un’illustrazione del paradosso dell’Alabama. Supponete che tre Stati A, B e C abbiano una popolazione rispettivamente di 2 milioni, 3,4 milioni e 4,8 milioni, e che ci siano 7 seggi in palio.

Il metodo più ovvio, che avrebbe voluto Jefferson, sarebbe quello di considerare quante volte la quota 10.200.000/7≈ 1.457.142 è interamente contenuta nei tre valori e poi assegnare i seggi rimasti a chi ha i resti più grandi. Ciò darebbe ad A un seggio con resto 542.858, a B due seggi con resto 485.716 e a C tre seggi con resto 428.574. Resterebbe quindi un seggio non assegnato che andrebbe ad A, che ha il resto più alto. Ma se adesso si decidesse di assegnare 8 seggi ai tre Stati, ovvero uno in più, e inoltre la popolazione di A addirittura crescesse fino a 2,1 milioni, cosa succederebbe? La quota diventerebbe 10.300.000/8 = 1.287.500 e quindi A avrebbe un seggio con resto 812.500, B due seggi con resto 825.000 e a C tre seggi con resto 937.500. Resterebbero quindi due seggi non assegnati che andrebbero a B e a C e quindi A, pur avendo aumentato la popolazione ed essendo aumentati i seggi perderebbe un rappresentante.
In Italia? C’è il metodo “dei divisori”. Per non incorrere in queste situazioni paradossali, oggi negli Stati Uniti si usa un sistema simile, ma non esattamente uguale, a quello utilizzato in Italia per ripartire i seggi, per esempio, tra le liste che hanno sostenuto un candidato sindaco. Dopotutto, assegnare i seggi in base alla popolazione oppure ai voti è, matematicamente, lo stesso problema di ripartizione. Il metodo usato in Italia è dovuto al matematico belga dell’800 Victor D’Hondt, detto anche metodo dei divisori.

Per illustrare la questione vi propongo un problemino. Supponiamo che vi siano 4 seggi in palio, 4 i partiti nella coalizione che ha eletto il sindaco, e 100 voti in tutto. Supponiamo che il partito A abbia ricevuto 48 preferenze, il partito B ne abbia ricevute 29, il partito C 16 e il partito D 7. Come pensate che sia più equo distribuire i 4 seggi?
L’equità è relativa. Non si può dare una risposta assoluta alla domanda, perché dipende dal concetto di equità di ciascuno di noi. Relativamente alle teorie della ripartizione, invece si può. Tutti i metodi concordano che al partito A devono andare 2 seggi, al partito B un seggio… ma a chi attribuire l’ultimo seggio? Il metodo del quoziente di Hamilton-Jefferson ripartisce i seggi pesandone ognuno con un numero di voti a priori, 25 voti in questo caso. Eventuali seggi non assegnati vengono poi ripartiti a chi ha il resto più alto: quindi 2 ad A, uno a B e uno a C. Il metodo dei divisori di d’Hont pesa ogni seggio a posteriori. Il peso è un numero di voti che permette di assegnare tutti i seggi senza lasciare resti maggiori del suo valore a nessun partito, per difetto o per eccesso. In questo caso un seggio vale qualunque numero strettamente maggiore di 15 e minore o uguale a 16. Quindi ad A vanno 3 seggi, uno a B e nessuno a C e a D. A voi dire se vi sembra equo.
La matematica è più equa di quanto sembri: pretende che ognuno si assuma la sua responsabilità nella scelta del metodo
Tutti i metodi dei divisori non sfuggono al Teorema di Balinski-Young perché hanno il difetto che in certe situazioni assegnano un numero di seggi addirittura superiore (come nel caso sopra) o inferiore alla quota a priori arrotondata per eccesso. Il metodo D’Hondt usato in Italia premia infatti i partiti più forti di una coalizione a scapito di quelli più deboli. Osservazione, questa, che dedico in particolare a chi ha ambizioni elettorali.
Quindi la morale qual è? Non è possibile calcolare l’equità? Forse sì. Sperare che i numeri possano compiere per noi le scelte etiche sarebbe troppo facile. Ma forse proprio così la matematica è molto più equa di quanto sembri: pretende che ognuno si assuma la propria responsabilità nella scelta del metodo!
Furio Honsell
 Furio Honsell è docente di Teoria degli Automi all’Università di Udine. Ha pubblicato oltre un centinaio di articoli scientifici sui fondamenti della matematica, la teoria dei tipi, la semantica dei linguaggi di programmazione, la dimostrazione formale e la certificazione formale del software, il lambda-calcolo, la teoria dei giochi, e la salute pubblica. Svolge inoltre un’intensa attività di promozione dell’alfabetizzazione matematica e della cultura del gioco come strumento di inclusione sociale. Attualmente cura la rubrica Giochi Furiosi sul supplemento Enigmistica del Sole 24 Ore. Ha pubblicato alcuni libri di giochi matematici (L’algoritmo del Parcheggio, Mondadori 2007). Ha collaborato con la trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio dal 2003 al 2006. Dal 2011 al 2018 è stato Presidente di GIONA, l’associazione nazionale dei comuni italiani che promuovono il gioco.
Furio Honsell è docente di Teoria degli Automi all’Università di Udine. Ha pubblicato oltre un centinaio di articoli scientifici sui fondamenti della matematica, la teoria dei tipi, la semantica dei linguaggi di programmazione, la dimostrazione formale e la certificazione formale del software, il lambda-calcolo, la teoria dei giochi, e la salute pubblica. Svolge inoltre un’intensa attività di promozione dell’alfabetizzazione matematica e della cultura del gioco come strumento di inclusione sociale. Attualmente cura la rubrica Giochi Furiosi sul supplemento Enigmistica del Sole 24 Ore. Ha pubblicato alcuni libri di giochi matematici (L’algoritmo del Parcheggio, Mondadori 2007). Ha collaborato con la trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio dal 2003 al 2006. Dal 2011 al 2018 è stato Presidente di GIONA, l’associazione nazionale dei comuni italiani che promuovono il gioco.