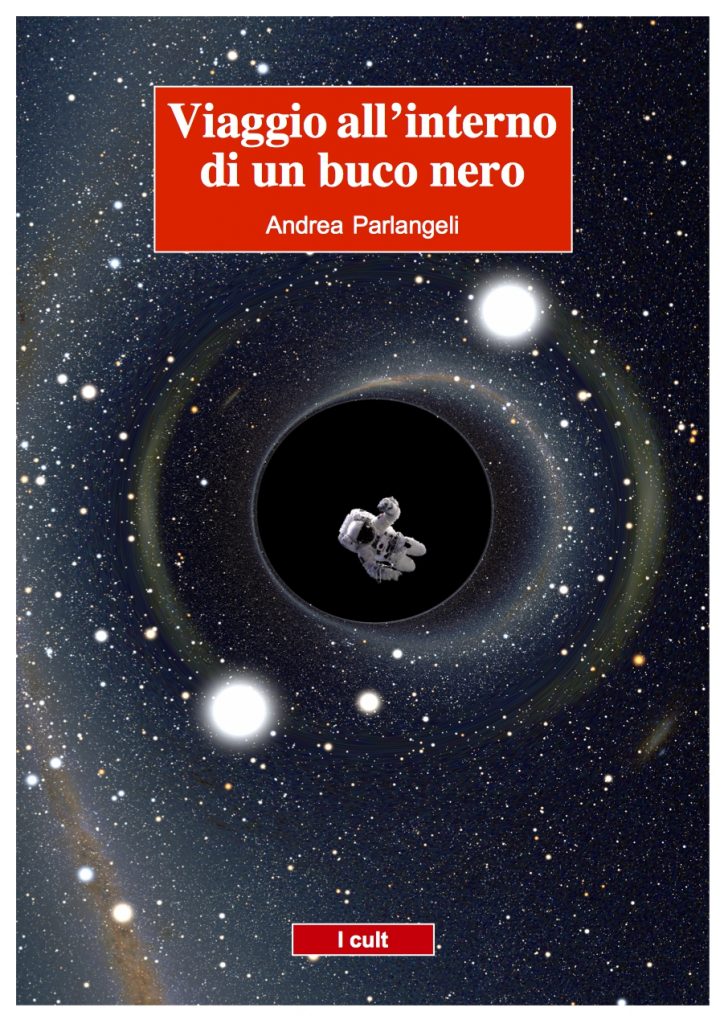Dopo il grande incendio di Roma del 64 d.C., l’imperatore Nerone ordinò la costruzione di una nuova residenza che per il suo sfarzo (a cominciare dall’oro che conteneva) e la sua grandiosità passò alla storia con il nome di Domus Aurea: un luogo straordinario, un gioiello del patrimonio italiano di nuovo visitabile dopo un lungo lavoro di restauro.
Subito in rovina
I padiglioni del palazzo, nel settore che oggi corrisponde a una parte del Colle Oppio, disponevano di 150 stanze, terrazze, fontane, statue. Una dimora dalle dimensioni suggestive, fuori dal comune, ma in linea con il pensiero imperiale di Nerone, che semplicemente esclamava che la Domus era finalmente “una casa degna di un uomo”. La residenza cadde però in disgrazia prima ancora di essere terminata, quando l’imperatore si suicidò nel giugno del 68 d.C.
Interrata e conservata
Nonostante la successiva dinastia degli imperatori Flavi abbia spogliato il palazzo neroniano dei materiali migliori, la struttura e buona parte degli affreschi e stucchi (qualcosa come 30 mila metri quadri di superfici, in parte attribuite a Fabullo), hanno resistito al tempo. Fu l’architetto Apollodoro di Damasco a ricoprire e interrare i resti del palazzo, per creare le premesse architettoniche delle Terme di Traiano e dare un nuovo uso agli spazi urbani sovrastanti. Questo interramento ha, in una certa misura, protetto la Domus Aurea e il suo tesoro per millenni.
Fonte d’ispirazione
In epoca medievale e rinascimentale vennero aperte alcune brecce che dall’umida terra dei giardini consentivano ad artisti, studiosi e semplici curiosi di accedere ad alcune zone alte delle enormi sale ripiene di terra (alcune toccano i 12 metri di altezza). Questi “esploratori” dei mondi antichi, calandosi con funi e lanterne, poterono contemplare decorazioni e affreschi ancora intatti. Giovanni da Udine, allievo di Raffaello, nel 1519, osservando nella penombra le grottesche romane della Domus Aurea, trasse ispirazione per decorare le Logge Vaticane. Altri, come il Pinturicchio, lasciarono una firma al loro passaggio.

Viaggio nel tempo
Le connessioni dell’immenso edificio con il vicino Palatino, con il Celio e con quello che fu il lago dove ora si erge il Colosseo, sono difficili da interpretare nell’oscurità del palazzo. L’effetto di spaesamento può essere forte ed è complicato immaginare questo luogo nella sua originale apparenza, in cui marmi colorati, riverberi di luce, ampie terrazze e fontane d’acqua giocavano con spazi gli architettonici interni ed esterni. Ma la magnificenza delle rovine, aiutata da uno sforzo di immaginazione, può far volare la mente oltre i tunnel, le volte e i criptoportici interrati, riportandola al I secolo d.C., quando Roma già si era consolidata come capitale di un immenso impero.

Il lavoro di restauro e di consolidamento degli ultimi anni, grazie all’attività minuziosa e ben organizzata di archeologi, architetti, ingeneri e operai esperti, ha permesso il recupero di questo monumento unico nel suo genere, rendendolo finalmente accessibile al grande pubblico. Un pezzo della storia è stato recuperato e inserito nel puzzle del patrimonio italiano e mondiale. Questo era l’obiettivo, che la memoria di un tempo lontano potesse riaffiorare dall’umida terra del Colle Oppio.
Link e approfondimenti
• Il sito del Parco Colosseo.
• Il sito dei Beni Culturali.
• Un articolo su archaeology.